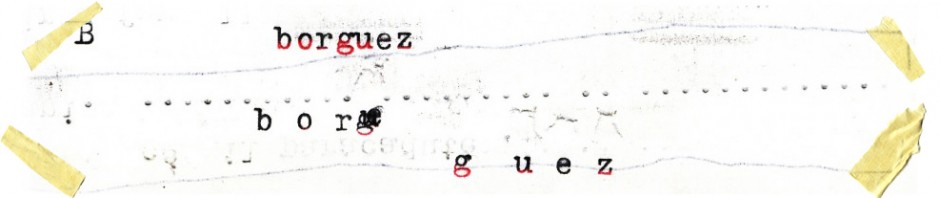è da quando ha preso forma quest’idea di blog, di questo blog, che rimando ed attendo un tempo idoneo per raccontare di un disco imprescindibile per la mia formazione e per la definizione della mia sensibilità musicale. in questi quattro anni ho tergiversato altrove oscillando fra l’imprecisa capacità di trovare idonee parole e la malcelata volontà di non esporre la nuda anima, l’istante privato dell’ascolto e della significanza appiccicata ai miei giorni.
tanto tempo è trascorso nell’attendere che nel frattempo è scomparso il leader del trio che, nel marzo e nell’agosto del 1961, entrò due volte in studio per incidere, in due diverse e singole session, i due dischi Fusion e Thesis che nel 1992 l’ECM di Manfred Eicher raccolse in un unico ed elegante doppio cd.
 Jimmy Giuffre è scomparso nell’aprile del 2008 dopo una carriera quieta e discreta ai margini del mondo del jazz. vi sarebbe assai da dire sulla sua traiettoria artistica e sulle difficoltà che incontrò la sua musica in costante frizione con il suo tempo e con le tendenze del jazz, ma il discorso sarebbe lungo e forse tedioso e in realtà successivo all’incisione di questo disco.
Jimmy Giuffre è scomparso nell’aprile del 2008 dopo una carriera quieta e discreta ai margini del mondo del jazz. vi sarebbe assai da dire sulla sua traiettoria artistica e sulle difficoltà che incontrò la sua musica in costante frizione con il suo tempo e con le tendenze del jazz, ma il discorso sarebbe lungo e forse tedioso e in realtà successivo all’incisione di questo disco.
 1961: ribadisco la data perché credo fermamente nella necessità di contestualizzare questo disco, per quanto difficile oggi, e collocarlo esattamente in quell’anno magico per il jazz, principio di un decennio ancor oggi eclatante.
1961: ribadisco la data perché credo fermamente nella necessità di contestualizzare questo disco, per quanto difficile oggi, e collocarlo esattamente in quell’anno magico per il jazz, principio di un decennio ancor oggi eclatante.
Jimmy Giuffre non era nuovo all’idea del trio e neppure alla sua concezione senza la batteria, ma la formazione composta dal pianista Paul Bley e dal bassista Steve Swallow doveva portare le sue idee musicali lontane dal decennio precedente e in uno spazio di avanguardia al tempo stesso classica e visionaria.
 Fusion (Verve, 1961) vede dunque il trio incidere per la prima volta assieme. nove composizioni originali: due di Carla Bley (Jesus Maria, On the Morning of the Mountain) e le restanti di Giuffre. è purezza, classe e inaudita bellezza. parti scritte si alternano a improvvisazioni in un legame complice e reciproco che chiamano interplay, ma che in questo caso andrebbe aggettivato oltremodo. liberato il suono dalla schiavitù del ritmo percosso dalla batteria, la musica pare spalancare le pareti della camera alla quale il trio sembrerebbe vocato e andarsene davvero altrove. folklore, blues, classica ma soprattutto il silenzio usato come quarto strumento ad interagire con il resto. il suono di Giuffre spaventa per concretezza ed equilibrio, una forza calma quieta e sorniona capace di intonare melodie che andranno a conficcarsi per sempre nella memoria vigile.
Fusion (Verve, 1961) vede dunque il trio incidere per la prima volta assieme. nove composizioni originali: due di Carla Bley (Jesus Maria, On the Morning of the Mountain) e le restanti di Giuffre. è purezza, classe e inaudita bellezza. parti scritte si alternano a improvvisazioni in un legame complice e reciproco che chiamano interplay, ma che in questo caso andrebbe aggettivato oltremodo. liberato il suono dalla schiavitù del ritmo percosso dalla batteria, la musica pare spalancare le pareti della camera alla quale il trio sembrerebbe vocato e andarsene davvero altrove. folklore, blues, classica ma soprattutto il silenzio usato come quarto strumento ad interagire con il resto. il suono di Giuffre spaventa per concretezza ed equilibrio, una forza calma quieta e sorniona capace di intonare melodie che andranno a conficcarsi per sempre nella memoria vigile.
 Thesis (Verve, 1961) è inciso pochi mesi dopo dallo stesso trio ma paiono passati lustri. consolidato il rapporto musicale dei musicisti si apre da qui in avanti la teorizzazione di quanto precedentemente intuito e fuso. irrompe l’avanguardia a scompaginare gli ultimi dettami di classicità rimasti impigliati nelle corde e nelle ance: si esplora la possibilità di una rinnovata libertà e di territori sconosciuti e, proprio per questo, bramati. ancora Carla Bley a comporre (Ictus) e Paul Bley a dedicare alla moglie un blues (Carla). c’è spazio per uno standard (Goodbye) e le restanti composizioni di Giuffre sono veri e propri tentativi di volo che si trasfigureranno nel successivo Free Fall del 1962 (Columbia). ma questo è già altro discorso.
Thesis (Verve, 1961) è inciso pochi mesi dopo dallo stesso trio ma paiono passati lustri. consolidato il rapporto musicale dei musicisti si apre da qui in avanti la teorizzazione di quanto precedentemente intuito e fuso. irrompe l’avanguardia a scompaginare gli ultimi dettami di classicità rimasti impigliati nelle corde e nelle ance: si esplora la possibilità di una rinnovata libertà e di territori sconosciuti e, proprio per questo, bramati. ancora Carla Bley a comporre (Ictus) e Paul Bley a dedicare alla moglie un blues (Carla). c’è spazio per uno standard (Goodbye) e le restanti composizioni di Giuffre sono veri e propri tentativi di volo che si trasfigureranno nel successivo Free Fall del 1962 (Columbia). ma questo è già altro discorso.
 lo slancio di Giuffre sembra qui esaurirsi: passeranno 10 anni (1962/1972) prima che torni ad incidere ed allora tutto sembra già successo e soprattutto nulla assomiglia più a niente, almeno nella musica. altre e diverse rivoluzioni hanno scosso il jazz ed il vicolo solitario additato da Giuffre pare non condurre in nessun luogo. nel 1992 Manfred Eicher comprende la potenza seminale di questo disco e ripropone i due lavori raccolti in un unico cofanetto, conseguenza inevitabile dopo la riformazione di quel trio che attraverserà gli anni ’90 con alcuni dischi memorabili (The Life of a Trio: Saturday, The Life of a Trio: Sunday) che non faranno altro che rammentare di una epifania dimenticata.
lo slancio di Giuffre sembra qui esaurirsi: passeranno 10 anni (1962/1972) prima che torni ad incidere ed allora tutto sembra già successo e soprattutto nulla assomiglia più a niente, almeno nella musica. altre e diverse rivoluzioni hanno scosso il jazz ed il vicolo solitario additato da Giuffre pare non condurre in nessun luogo. nel 1992 Manfred Eicher comprende la potenza seminale di questo disco e ripropone i due lavori raccolti in un unico cofanetto, conseguenza inevitabile dopo la riformazione di quel trio che attraverserà gli anni ’90 con alcuni dischi memorabili (The Life of a Trio: Saturday, The Life of a Trio: Sunday) che non faranno altro che rammentare di una epifania dimenticata.
il tempo non ha tradito questi dischi perché al tempo non appartenevano. oltre, altrove in un’imprecisata collocazione restano a splendere in attesa di essere percepiti da chi ha sensibilità per intendere. del tempo implicito e sotteso i tre si fecero discreti portavoce, accolsero il sacrosanto silenzio e lo addobbarono di misurata bellezza. tutto questo ho avuto la fortuna di incontrare e da allora mi è impossibile prescindere. canone di eleganza, stile e occidentale bellezza. 1961, ma non importa oramai più.