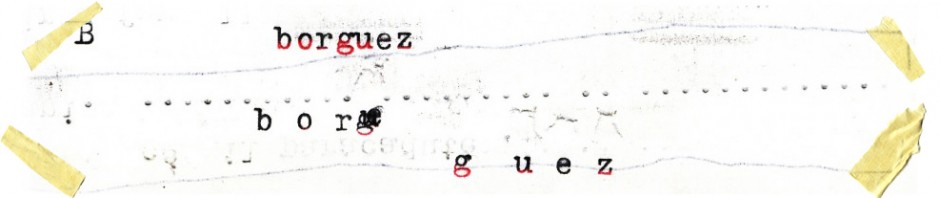esulo un poco dalle consuete questioni che riempiono questo spazio: ma neppure troppo. mi è soggiunta un’anomala tentazione di onorare e tributare il giusto ringraziamento ad un oggetto che da più di un anno mi accompagna indefesso e silenzioso (o quasi), prezioso esempio di come, non sapendo se davvero il fine giustifica i mezzi, a volte i mezzi glorificano il fine.
sto parlando delle mie cuffie (portatili, tascabili) che gli specialisti definiscono in-ear. un solerte commesso di un grande store me le presentò entusiasta esulando per un breve istante dagli intenti commerciali del suo datore di lavoro. mi fece capire con un’occhiata che quelle, e non altre, rappresentavano il miglior rapporto qualità prezzo, snobbando e insinuando disgrazie a proposito di quelle bianche ed ufficiali che ogni iPod vorrebbe con sé. e non si sbagliava.
AKG K 315 (marca e modello) fecero immediatamente capire di che pasta erano fatte, e nonostante i quasi 30 euro che dovetti esborsare, mi ritrovai proiettato in una nuova dimensione sonora della quale ero ignaro. una relazione che durò poco più di un mese perché un bel mattino mi ritrovai il canale destro defunto e irrimediabilmente perduto. due ore dopo avevo una copia gemella di cuffie identica a quella che avevo appena seppellito, a dimostrazione che l’epifania del primo istante continuava a guidare i miei gesti.
 quel secondo paio è dunque con me da più di un anno e subisce da allora uno stress quotidiano che si agira dalle 3 alle 5 ore. stress dovuto alla qualità di musica ascoltata e ancor più dalla serie infinita di arrotolamenti, attorcigliamenti, strappi, cadute e di tutta la polvere che si beve nel mio peregrinare lavorativo.
quel secondo paio è dunque con me da più di un anno e subisce da allora uno stress quotidiano che si agira dalle 3 alle 5 ore. stress dovuto alla qualità di musica ascoltata e ancor più dalla serie infinita di arrotolamenti, attorcigliamenti, strappi, cadute e di tutta la polvere che si beve nel mio peregrinare lavorativo.
senza scendere in dettagli tecnici che ciascuno può trovare in questa scheda, e senza indagare sul mio insano rapporto con il materiale “tecnico” in genere, sia bastante questa mia sperticata lode per un oggetto che mi stupisco di trovare ancora integro nelle mie mani, mezzo beatificatore di gradito isolamento dalle nefandezze verbali del popolo italiota e, ancor più, messo angelico di musiche che provengono dal luogo più incredibile che mi sia concesso portare in tasca: il mio iPod.
precisando che non percepirò denaro per quanto sopra scritto (semplicemente perché non mi è stato offerto), termino qui quello che potrebbe pure essere un semplice consiglio per gli acquisti, ma che è per me un tributo doveroso e emozionato.
p.s. visto che la sfortuna e la scaramanzia parlano lingue diverse, preciso ulteriormente che se, a causa di quanto scritto, dovessi trovarmi assai presto a seppellire le mie care compagne auricolari, non esiterei ad acquistarne immantinente un paio ulteriore.
(speriamo che serva)
settimanalmente
borguez
social
la radio uabab

la radio uabab 2012/2013
la radio uabab 2013/2014
la radio uabab 2014/2015
la radio uabab 2015/2016
la radio uabab 2016/2017
la radio uabab 2017/2018
la radio uabab 2018/2019
la radio uabab 2019/2020
la radio uabab 2020/2021
la radio uabab 2021/2022
la radio uabab 2022/2023
la radio uabab 2023/2024
la radio uabab 2024/2025
podcastpanoptikum
search
categories
- 100 Records that Set the World on Fire (While No One Was Listening)
- 2008
- 2009
- 2010
- 2010 review
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2019
- 2020
- 2024
- : inmaraviglia;
- alice
- Ao Vivo
- Blog
- Brace
- Costantino Spineti
- Date
- Edoardo Orofino
- Fred Bongusto
- Gabriele Savoja
- Gianni Celati
- Gulp!
- home
- iNmobilità
- International Anthem
- Kino
- la radio uabab
- la radio uabab 2012/2013
- la radio uabab 2013/2014
- la radio uabab 2014/2015
- la radio uabab 2015/2016
- la radio uabab 2016/2017
- la radio uabab 2017/2018
- la radio uabab 2018/2019
- la radio uabab 2019/2020
- la radio uabab 2020/2021
- la radio uabab 2021/2022
- la radio uabab 2022/2023
- la radio uabab 2023/2024
- la radio uabab 2024/2025
- Libercoli
- Lupo
- Lupo340
- Marco Boccitto
- Mixtape
- Nicola Altieri
- Nina
- Ortometropolis
- Pino Saulo
- Playlist
- Radio
- Senza categoria
- settimanalmente
- Songs, Canções, Canzoni, Chansons, Gesänge
- The Quietus Baker's Dozen
- uabab
- Unearthly Delights: Eric Chenaux’s Favourite Albums
- Vita Nova
- White Album
- Zen.Zero
- zzaj
archive
- Maggio 2025
- Aprile 2025
- Marzo 2025
- Febbraio 2025
- Gennaio 2025
- Dicembre 2024
- Novembre 2024
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Maggio 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
- Dicembre 2019
- Novembre 2019
- Ottobre 2019
- Giugno 2019
- Maggio 2019
- Aprile 2019
- Marzo 2019
- Febbraio 2019
- Gennaio 2019
- Dicembre 2018
- Novembre 2018
- Giugno 2018
- Maggio 2018
- Aprile 2018
- Marzo 2018
- Febbraio 2018
- Gennaio 2018
- Dicembre 2017
- Novembre 2017
- Ottobre 2017
- Settembre 2017
- Luglio 2017
- Giugno 2017
- Maggio 2017
- Aprile 2017
- Marzo 2017
- Febbraio 2017
- Gennaio 2017
- Dicembre 2016
- Novembre 2016
- Ottobre 2016
- Settembre 2016
- Luglio 2016
- Giugno 2016
- Maggio 2016
- Aprile 2016
- Marzo 2016
- Febbraio 2016
- Gennaio 2016
- Dicembre 2015
- Novembre 2015
- Ottobre 2015
- Settembre 2015
- Agosto 2015
- Luglio 2015
- Giugno 2015
- Maggio 2015
- Aprile 2015
- Marzo 2015
- Febbraio 2015
- Gennaio 2015
- Dicembre 2014
- Novembre 2014
- Ottobre 2014
- Settembre 2014
- Agosto 2014
- Luglio 2014
- Giugno 2014
- Maggio 2014
- Aprile 2014
- Marzo 2014
- Febbraio 2014
- Gennaio 2014
- Dicembre 2013
- Novembre 2013
- Ottobre 2013
- Settembre 2013
- Agosto 2013
- Luglio 2013
- Giugno 2013
- Maggio 2013
- Aprile 2013
- Marzo 2013
- Febbraio 2013
- Gennaio 2013
- Dicembre 2012
- Novembre 2012
- Ottobre 2012
- Settembre 2012
- Agosto 2012
- Luglio 2012
- Giugno 2012
- Maggio 2012
- Aprile 2012
- Marzo 2012
- Febbraio 2012
- Gennaio 2012
- Dicembre 2011
- Novembre 2011
- Ottobre 2011
- Settembre 2011
- Agosto 2011
- Luglio 2011
- Giugno 2011
- Maggio 2011
- Aprile 2011
- Marzo 2011
- Febbraio 2011
- Gennaio 2011
- Dicembre 2010
- Novembre 2010
- Ottobre 2010
- Settembre 2010
- Agosto 2010
- Luglio 2010
- Giugno 2010
- Maggio 2010
- Aprile 2010
- Marzo 2010
- Febbraio 2010
- Gennaio 2010
- Dicembre 2009
- Novembre 2009
- Ottobre 2009
- Settembre 2009
- Agosto 2009
- Luglio 2009
- Giugno 2009
- Maggio 2009
- Aprile 2009
- Marzo 2009
- Febbraio 2009
- Gennaio 2009
- Dicembre 2008
- Novembre 2008
- Ottobre 2008
- Settembre 2008
- Agosto 2008
- Luglio 2008
- Giugno 2008
- Maggio 2008
- Aprile 2008
- Marzo 2008
- Febbraio 2008
- Gennaio 2008
- Dicembre 2007
- Novembre 2007
- Ottobre 2007
- Settembre 2007
- Agosto 2007
- Luglio 2007
- Giugno 2007
- Maggio 2007
- Aprile 2007
- Marzo 2007
- Febbraio 2007
- Gennaio 2007