nel 2009 ho ascoltato così tanta musica che il miglior auspicio che possa farmi per l’anno appena iniziato è di ascoltarne almeno altrettanta. è definitivamente esplosa e si è cronicizzata la mia inguaribile esigenza di ascoltare, scoprire e curiosare attorno al mondo dei suoni: avrei già potuto saperlo all’età di 6 o 7 anni, ci è voluto un poco di più, ma ci sono arrivato comunque.
continuo irrimediabilmente ad ascoltore di tutto, oltre i generi, il tempo e molto spesso oltre quelli che pensavo fossero i miei gusti. mi muovo senza confini in un territorio apparentemente immenso con una bussola rodata e parzialmente arrugginita: riescono a darle noia solamente l’opera, il noise estremo e chi fa finta – ciò che resta mi trova disponibile.
annata di termine e di passaggio verso la decina successiva, chiave cruciale verso ciò che sarà: mi permetto l’artificio di individuare grandi aree dei miei ascolti per trarre fuori una decina di dischi che tenteranno di tratteggiare l’anno oramai fuggito.
 vecchi leoni
vecchi leoni
non hanno mancato di ruggire e di far sapere ai cuccioli riottosi chi ancora detiene regale discendenza e venerabile conoscenza: Bob Dylan segna ancora svogliatamente il tempo, Tom Waits ha preso una tangente irraggiungibile per chiunque, Leonard Cohen deve aver scoperto qualche fonte miracolosa di purezza, Joe Henry studia per divenire gigante, Lee Perry è caduto nel dub da piccolo e non abbisogna che di una miccia per riappicciarsi, Ramblin’ Jack Elliott è l’unico credibile zio d’America e David Sylvian è il santone della mia religione silenziosa (ammesso che io ne abbia una).
ma il vero ruggito giunge dalla culla della civiltà etiope, sorvola questo tempo distratto e si pone, viscerale e siderale, nel groove ipnotico del tempo che verrà: un vero ponte sotto al quale ci si deve ritenere fortunati di esser potuti passare.
 cantautorato adulto
cantautorato adulto
amo la canzone costituita di quel niente che è capace di mettere in piedi il cantautorato, quello adulto e consapevole. i bardi di questa dottrina non hanno mancato di distinguersi: stavo per dire che Vic Chessnutt aveva raggiunto l’apogeo del suo songwriting ma lui non ha più avuto voglia di ascoltare. poi Bonnie ‘Prince’ Billy che non ci fa mancare la messe annuale di bellezza, Bill Callahan che non vorrei citare da fan geloso di condividere, Brian Blade che mi ha sorpreso, James Yorkston & The Big Eyes Family Players che sarà bene i vecchi nostalgici di certo folk non perdano d’occhio e Richard Hawley che ammansisce le mie disparità.
ma il debutto di questo fanciullo imberbe ha sbaragliato la concorrenza: oscure profondità stracolme di bellezza, strutture sghembe e notturne, una voce perfetta per cantare canzoni perfettamente diverse. sta ancora crescendo ascolto dopo ascolto e io non posso che attendere un seguito.
 l’altra metà del cielo
l’altra metà del cielo
alla fine è sempre una donna che ti frega! chiosava un qualche western di cui non ricordo più titolo o circostanze: le pulzelle della canzone non hanno mancato di moltiplicarsi e di incantare così come da molti anno accade. la scoperta di Tiny Vipers va accolta con letizia, Hope Sandoval ha sposato notte e oscurità e trova le mie felicitazioni, Elysian Fields hanno quel fare ruffiano e sornione al quale finisco per cedere, Tara Jane O’Neil è alla ricerca del volo definitivo verso la consacrazione e Alela Diane prova ad imitarla.
ma io sono cocciutamente innamorato di una maniera antica di salmodiare canzoni, di una grazia goffa da albatros e di un folk ancestrale ancora per oggi inarrivabile. specchio, specchio delle mie brame…
 afrolatinamerica
afrolatinamerica
quel grande bacino culturale che ha l’oceano atlantico come confine continua a fluttuare e ad alzarsi con le maree. le sponde di quel luogo rimbalzano suoni che si intensificano e si mischiano da secoli. parlano la lingua del paese più ad ovest d’europa.
Caetano Veloso porta la bandiera, Maria Bethânia l’orgoglio muliebre della tradizione, Yoñlu è la promessa che ha voluto negarsi, Cesaria Evora la musa di una saudade sciabordante, Bonga l’entusiasmo mai domo e Deolinda la declinazione più giovane del vecchio continente lusitano.
ma il giaggiolo più sorprendente e iridescente rinasce ogni volta da una nuova marea, da una nuova generazione figlia di uno dei più importanti patrimoni folclorici popolari: ed è meraviglioso!
 afrique
afrique
la terra madre non smette di chiamare, di ingigantirsi all’orizzonte dell’occidente idiota e perduto. da laggiù (lassù?) provengono battiti cardiaci ancora veri, entusiasmi antichi e segreti inattesi. Bassekou Kouyate ha realizzato un disco ancor più bello del precedente e come abbia fatto non pretendo di saperlo, ho visto Oumou Sangare incarnare l’orgoglio e la fierezza delle donne africane e lo Staff Benda Bilili sovvertire l’ordine del fato e del destino. ma la mia scelta raggiunge lo spirito di combattenti che credevo sconfitti: le ultime prove avevano affievolito l’ardore degli esordi, le chitarre addolcite, le parole sedate e le sirene della celebrità tendevano imboscate. sbagliavo: mai dare per morti dei guerriglieri!
 ridd’m (beat/hip/soul)
ridd’m (beat/hip/soul)
la mia piccola percentuale di negritudine sanguigna continua a scuotersi al battito dell’anima soul. subisco il fascino di un suono che non mi appartiene per formazione ma al quale ambisco per tentazione. The Sa-Ra Creative Partners una delle conferme cosmiche con la sua appendice oltranzista di Shafiq Husayn. Georgia Anne Muldrow ha riportatato il battito in casa d’Africa e splende di luce propria, mentre le Dillanthology della Rapster ci ricordano cosa abbiamo perso. e se Madlib è fuori categoria da assai, allora il beat più interessante e caustico è (per ora) l’ep degli EarPeace: li attendo al varco. ma è nel gotha degli mc’s che vado a pescare questa gemma scintillante: appartiene di certo al mainstream e alla cultura pop di vasta scala, ma non è peccato: possiamo dire che i Beatles non fossero mainstream?
 ambiente
ambiente
ho riempito il mio ambiente amniotico di suoni sempre più rarefatti e dilatati, ho virato decisamente, nell’anno trascorso, verso la conoscenza dell’approccio digitale e elettroacustico. ho fatto scoperte liete e mi riservo di imparare ancora. mi sono stati fidi compari i sempre amati Gentleman Losers, e mi sono sinceramente emozionato viaggiando in auto con Fuqugi. Fennesz ha inventato una nazione dove chiedere asilo e Musette ha distillato la primavera in musica. Les Lendemain e i Mountains hanno aperto orizzonti che il prossimo anno vorrei completare. il viaggio più profondo però è stato quello accompagnato da una voce sodale che mi ha guidato alle radici di un suono americano ancora da esplorare, verso la conoscenza di un compositore geniale e discreto.
 avant (un poco oltre verso l’altrove)
avant (un poco oltre verso l’altrove)
le musiche che esplorano i confini della galassia segnano il passaggio ai futuri possibili, è bene prestargli orecchio e ascolto per sapere, con buona approssimazione, dove approderemo. suoni che mischiano attitudini e discipline, estrazioni culturali e sperimentazione. i Digital Primitives sono la piu straordinaria sorpresa di un suono che non smette di stupire, Pascal Comelade si è sobbarcato il suono europeo sulle spalle e lo porterà dove meglio crede. i Land of Kush soddisfano il fabbisogno lisergico di ogni idividuo di buona volontà, mentre John Zorn abbisogna di una dozzina di biografi per annotare diligentemente le frenetiche uscite discografiche. Paul Baran è il nome che rimane appuntato prima di gettarsi interamente nell’anno nuovo. fra questa babele di suoni mi sono lasciato irretire da un viaggio sicuro condotto da nocchieri esperti verso le lande arabo-mediorientali: ambra e delizia, saggezza e muta riconoscenza.
 band
band
non saprei esattamente specificare quale macrocategoria rappresenti la definizione band nel mio apparato (audio)cognitivo: credo riguardi la creazione multipla, la polifonia vocale, la commistione di teste e idee. i Grizzly Bear potrebbero vincere a guantoni calati, ma da loro, sadicamente, so di poter attendere il reale capolavoro. Animal Collective e Dirty Projectors trovano il mio ascolto curioso e consapevole, conscio di trovarsi di fronte la frontiera più avanzate del pop corale 2009: resto stupito di come non finiscano per piacermi assolutamente, ma poi non lo dico, lo tengo per me, o al limite lo scrivo in un blog. la vera sorpresa, per questo, parla ispanico, mi confonde nel caos di suoni e voci e stordisce la mia attenzione: disco misterioso che ancora ascolto e che mi accompagnerà anche in quest’anno debuttante.
 ristampe, riemersioni, riscoperte
ristampe, riemersioni, riscoperte
il mio udito è anziano, nel senso che non smette di credere di avere un fututo misterioso alle spalle. il tempo, la rete e qualche speleologo di buon gusto non smette di riemergere dal passato con leccornie e vere e proprie epifanie. il mondo delle ristampe basterebbe (forse) a soddisfare la mia ansia di ascoltare. Betty Davis chi l’aspettava più? il lavoro della Analog Africa meriterebbe il Nobel per la bellezza (Legends of Benin, Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou), così come la Strut Records o la Honest Jones Records, 0 ocosì come della Soundway vale quanto appena detto. io però resto incantato di fronte alla freschezza di una voce e di un suono ondulanti, al ritmo blando che addolcisce gli animi e alle straordinaria modernità di un calypso di mezzo secolo indietro. bellissimo!
sono arrivato in fondo, credo. chiedo venia se ho annoiato e a tutti quelli che mi sono dimenticato, ma il nuovo anno è già qui e del 2009 presto ci si sarà già scordati. ecco dunque dieci dischi che ricorderò, sono in ordine sparso (tranne il primo) e tutti ascoltabili (a buon intenditore): a presto!
Mulatu Astatke & The Heliocentrics Inspiration Information
DM Stith Heavy Ghost
Josephine Foster Graphic As A Star
Mayra Andrade Stòria, Stòria…
Tinariwen Imidiwan:Companions
Mos Def The Ecstatic
Brian Harnetty & Bonnie ‘Prince’ Billy Silent City
Kronos Quartet Floodplain
Savath & Savalas La Llama
Blind Blake & The Royal Victoria Hotel Calypsos Bahamian Songs
 per chi ama i concept album (io alzo la mano) questo vaudeville circense potrebbe davvero rappresentare una lieta delizia. l’idea è quella antica e mai sfiorita di Phineas Taylor Barnum: raccogliere e mostrare le deformità, le stranezze e le brutture come fossero epifaniche meraviglie di cui ridere, emozionarsi o ritrarsi offesi. in realtà è il gioco dello specchio rivolto verso il pubblico che (ignaro) addita il freak ridendo infine di se stesso e dei suoi simili.
per chi ama i concept album (io alzo la mano) questo vaudeville circense potrebbe davvero rappresentare una lieta delizia. l’idea è quella antica e mai sfiorita di Phineas Taylor Barnum: raccogliere e mostrare le deformità, le stranezze e le brutture come fossero epifaniche meraviglie di cui ridere, emozionarsi o ritrarsi offesi. in realtà è il gioco dello specchio rivolto verso il pubblico che (ignaro) addita il freak ridendo infine di se stesso e dei suoi simili.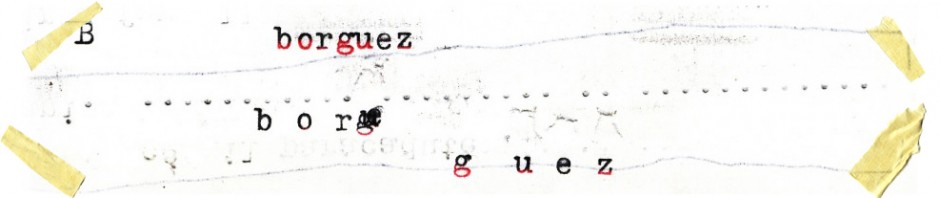














 vecchi leoni
vecchi leoni






 band
band



