da oramai troppe ore sono combattuto nel dilemma di scrivere o non scrivere del concerto di Bill Callahan al Bronson. le emozioni si sono aggrovigliate, i pensieri contratti e le parole non ci hanno guadagnato. un paio di notti di sonno non sono bastate per derimere il dubbio e solamente stamattina una schiarita ha lasciato dipanare le incertezze e rilasciare la favella.
aspettavo questo concerto da così tanto tempo che la faccenda stava assumendo contorni beckettiani. e l’attesa non ha fatto altro che ingigantire le mie aspettative. e questo assomiglia già ad un mea culpa. ma qualcosa l’altra sera è andato storto. come un abito sbagliato al primo appuntamento, una parola di troppo ad un funerale, un cappello sul letto. ho pensato e ripensato cosa ha impedito che si svelasse l’incanto, che si schiudesse l’emozione e ho raccimolato alcune considerazioni.

qualcosa nella band che lo accompagnava non ci stava. e non era l’abilità tecnica o la presenza scenica, e neppure il suono, peraltro ricercato e scarno, ma piuttosto tutta quell’elettricità, quel roboante contorno che distingue il metallo freddo dal calore del legno, la parte che fa rumore da quella che esige un silenzio. lo stesso silenzio che il pubblico ha osservato, quasi devoto e quasi sacrale.
perché le canzoni di Callahan (avrei potuto scrivere le creature) di essenziale sono fatte e di essenziale si nutrono. come tutte le grandi canzoni. necessitano di abiti sobri, di scarni decori e di quel poco di cui sono fatte le cose semplici. avrei preferito un live che indulgesse alla riduzione e alla sottrazione e invece ho visto sommarsi suoni, chitarre e una percussività che riempiva quel piccolo contenitore che è una canzone degli Smog. fino quasi ad oscurare quella voce.
quella voce che avrebbe avuto bisogno di un controcanto femminile per diluire il veleno mortale di quella pasta sonora, come faceva Cohen. quella voce che avrebbe avuto solamente bisogno di una sedia e di una chitarra acustica come compagni. ma la scelta artistica, questa volta, ha probabilmente cercato altro.
la leggenda vuole Callahan costantemente pervaso da un atteggiamento dimesso, che poco concede al pubblico, senza fronzoli e ammiccamenti. questo l’ho apprezzato e del resto anche Dylan ha sempre riso poco. quell’aria blasé mi ricordava Lou Reed che canta capolavori come fossero posologie di un bugiardino.
cercavo in rete prove delle mie impressioni. poco ho trovato. belle foto di Adele, quelle sì, ma nessuna prova audio del live dell’altra sera. e cercando e ricercando ho comparato lo show di Parigi del 16 maggio scorso con questa Sycamore. e a buon intenditore intendere che non si tratta di qualità sonora o video.
ma la colpa probabilmente resta la mia. io che mi sono spinto così addentro agli ascolti dei suoi dischi da aver perso le coordinate, da aver smarrito un’ipotetica via di ritorno. ed è per questo che forse chiedevo tutto e troppo, subito e assolutamente. le sue canzoni restano, le mie impressioni poco importano.
Because there is no love, where there is no obstacle…
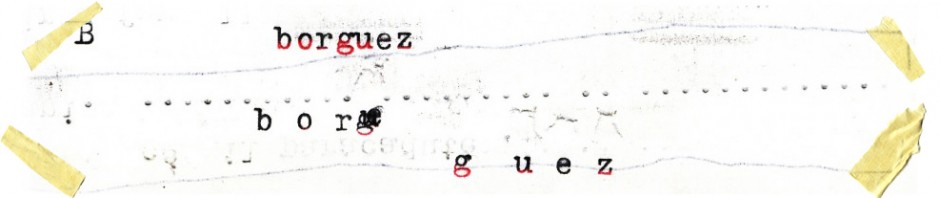




Un attimo. Non dimentichiamo da dove Bill è venuto…
proprio tra i tuoi five easy pieces figurava pochi giorni orsono quel Julius Caesar che fu capolavoro emblematico, gran connubio tra estro compositivo, lo-fi ed incursioni elettriche impertinenti. E proprio una delle canzoni che ho sentito richiedere più volte l’altra sera è quella Prince alone in the studio (Wild Love) che dallo stesso punto di vista pare una discesa agli inferi. E quanti esempi ancora?
Ovvio che queste sono sue scelte (la scelta della band) e che certe scelte ne implicano altre (la scelta dei brani). Nonostante ciò se pensiamo all’esecuzione di Say valley maker o Rock bottom riser ci torna ancora la pelle d’oca.
L’affaire con Joanna Newsom è cosa recente e auspico che ci saranno venture occasioni per apprezzarlo. All’ATP lo vidi con tastiere, chitarra acustica e una violinista e la scaletta fu in gran parte dedicata a Woke on a whaleheart. Forse tu l’avresti lì e non ti biasimo, anzi condivido il tuo gusto personale, ma stavolta mi ha offerto uno straordinario diversivo e sono stato davvero felice di ascoltare anche quel che fu Smog, perchè con quella scaletta imprevista ci ha raccontato tanto della sua storia.
“l’avresti preferito lì e non ti biasimo”, sorry.
mi sa che concordo con diego. però so cosa intende borguez
diego, mi va di spiaccicare qualche parola qui, di rischiarla senza potere nè voler essere quella che “ci capisce sempre qualcosa”. (e oggi sospendiamo la gara a punti…)
non conoscevo e non conosco bill callahan.
conoscevo la sua voce perfetta. e conosco la sua voce perfetta.
in quella voce ci si può perdere come un dante alighieri che ne esplora le sfumature.
ma vorrei solo dire (timidamente, perché so di non avere argomentazioni con fondamenta nelle profondità) che un concerto non è solo voce. non è nemmeno solo canzoni.
un concerto è fatto d’altro. è fatto di una sottile magia che deve uscire.
mi sono chiesta “perché tutto così elettrico?”, ho pensato “mi piacerebbe me lo concedessero un minuto senza chitarra senza microfono senza nessuno”…
già, idee da bambina…
mi sono sorpresa (giudico la sorpresa parte di quella magia che dovrebbe commuoverci) solo quando Alasdair Roberts ha concesso note melodiche e semplici alle corde di quella voce che nulla dovrebbe aggiugere.
ma è anche vero che le aspettative sono in tutti differenti, che ognuno è fatto di pelle propria che rabbrividisce a tocchi diversi. quindi questa è solo un’opinione e pure piccola.
quella faccina non la volevo. quella proprio no. ma salta fuori da sola.
alice, apprezzo il tuo commento. nondimeno sono convinto e sostengo il mio.
quella sottile magia… conosco gente che la coglie mettendosi seduta a gambe incrociate davanti al riverbero monocromatico di un amplificatore che fa sanguinare i timpani (penso ad un amico ed al drone dei sunn o)))). Dal canto mio non c’entra l’elettricità o meno, adoro bill callahan in qualsiasi salsa! e magari più tardi scriverò il perchè. magari altove, per non monopolizzare questo spazio…
(peggio delle faccine automatiche in wordpress ci sono solo gli avatar-trip-geometrici, automatici pure quelli!)
davvero! questi avatar sono insostenibili. e superflui, non necessari, in aggiunta.
Elamadonna,qui sembra di essere al festival di newport del ’65…!
non è Newport e neppure Caporetto!
è una piccola opinione personale, uno sfogo se si vuole.
e rileggendo mi accorgo di essermi dimenticato il paragrafo in cui dico di quella Say Valley Maker vista eseguire di fronte ai miei occhi, di una Our Anniversary tirata fuori dal cilindro inatteso delle sorprese.
proverò a rispondere…
adesso sono le 7.15 del mattino e fuori sembra di essere a Saigon, fra la nebbia e la camicia appiccicata alla schiena. vado al lavoro e continuo a pensare.
grazie a chi è voluto intervenire.
Uhm, capisco cosa intendi. Fatto ragionamento analogo, ma durante il set di Six Organs Of Admittance, peraltro molto bello. Molto d’impatto però, a tratti all’arma bianca, dunque poche sfumature. Il buon Bill, chissà perché, me lo aspettavo così.
anch’io Hank capisco spesso (quasi spesso) ciò che intendi e da due chitarre, un basso e una batteria ci si può aspettare di tutto, eccetto un unplugged!
e del resto, come recitava quella cariatide di Lou Reed sulla “nostra” bibbia pagana:
“You can’t beat two guitars, bass & drums”