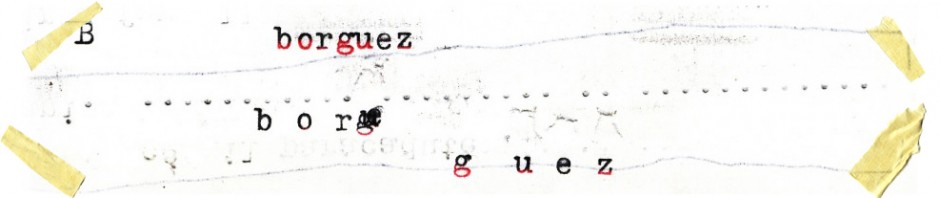per molte vie e per diverse circostanze si procede nell’errabonda attività di nutrirsi di musica; mi capita spesso di ragionarci sopra, per diletto o per segreta ambizione di comprendere logiche e discrimini che guidano gusti e scelte. materia selvatica e cisposa che si inspessisce vieppù che ci si inoltra alla ricerca di affidabili argomenti. di certo, uno dei parametri che più spesso usiamo è quello della similitudine, dell’assonanza riconosciuta e, per questo, gratificante.
la piacevole costruzione di una topografia sonora che ci appartiene diventa il bilancino da tasca con il quale soppesiamo e rimiriamo le novelle novità che giungono ai nostri orecchi. l’attitudine a confermare (o spiazzare) le nostre inclinazioni e il rinvenimento di appigli o capisaldi al quale aggrapparsi per procedere oltre sono attività (oramai) inconsce alle quali affidiamo la letizia (o la delusione) che ci procura una musica inattesa e inaudita.
 l’ultimo disco dei Clogs entra nella sfera dei miei ascolti per diverse attinenze e per conclamate ascendenze pregresse. The Creatures in the Garden of Lady Walton (Brassland, 2010) nasce dalla contempozione botanica dei Giardini La Mortella di Ischia, voluti curati e conservati da Lady Susanna Walton (da poco scomparsa) già vedova del musicista Sir William Walton. l’incontro fra Padma Newsome e le meraviglie botaniche avvenne nel 2006 in uno di quei gran tour che spesso affascinarono e suggestionarono artisti di altre epoche. nacque lì il progetto di comporre questi acquerelli sonori per ritrarre le immaginarie creature che abitano la verzura del giardino mediterraneo.
l’ultimo disco dei Clogs entra nella sfera dei miei ascolti per diverse attinenze e per conclamate ascendenze pregresse. The Creatures in the Garden of Lady Walton (Brassland, 2010) nasce dalla contempozione botanica dei Giardini La Mortella di Ischia, voluti curati e conservati da Lady Susanna Walton (da poco scomparsa) già vedova del musicista Sir William Walton. l’incontro fra Padma Newsome e le meraviglie botaniche avvenne nel 2006 in uno di quei gran tour che spesso affascinarono e suggestionarono artisti di altre epoche. nacque lì il progetto di comporre questi acquerelli sonori per ritrarre le immaginarie creature che abitano la verzura del giardino mediterraneo.
i Clogs hanno voluto al loro fianco colleghi ed amici: Shara Worden (My Brightest Diamond), Sufjan Stevens, Aaron Dessner e Matt Berninger (National) e la valente collaborazione dell’Osso String Quartet. ne è nato un album per dieci quadri da camera, clorifilliaco e aereo, placato e posato come la quiete della contemplazione vegetale. canzoni e partiture acustiche si alternano a voci e coralità di un tempo sospeso; si procede con passo lento e malinconico nella passeggiata meditabonda fra sonorità antiche e ancestralità remote. questo lavoro fu preceduto a gennaio da un ep dal titolo Veil Waltz che ne anticipava ambientazioni e traiettorie.
 ritorno alla premessa: ho cercato (e meditato) di racchiudere l’emozione di questo ascolto perimetrando e riconoscendo precedenti evocazioni che hanno spalancato a questo lavoro dei Clogs le porte accessibili del mio stupore. dagli amati Penguin Café Orchestra di Simon Jeffes sono giunto per sentieri traversi alle antiche suggestioni dei Dead Can Dance che hanno aperto la visuale sulla contemplazione di The Draughtsman’s Contract (I Misteri del Giardino di Compton House), nell’accezione visuale del regista Peter Greenaway e ancor più nella puntuale colonna sonora di Michael Nyman che prese spunto dagli ostinati settecenteschi di Henry Purcell. a tutto questo si aggiunga la naturale attitudine bucolica di molta musica folk che, senza scomodare i santi, tesse un lungo percorso che potrebbe andare, più o meno, da Nick Drake all’altettanto amata Baby Dee. nel bel mezzo di questo giardino così determinato da miei confini conosciuti e dalle mie traiettorie passate non è difficile riconoscere queste creature del giardino di Lady Walton e addentrarsi serenamente verso ulteriori camminamenti.
ritorno alla premessa: ho cercato (e meditato) di racchiudere l’emozione di questo ascolto perimetrando e riconoscendo precedenti evocazioni che hanno spalancato a questo lavoro dei Clogs le porte accessibili del mio stupore. dagli amati Penguin Café Orchestra di Simon Jeffes sono giunto per sentieri traversi alle antiche suggestioni dei Dead Can Dance che hanno aperto la visuale sulla contemplazione di The Draughtsman’s Contract (I Misteri del Giardino di Compton House), nell’accezione visuale del regista Peter Greenaway e ancor più nella puntuale colonna sonora di Michael Nyman che prese spunto dagli ostinati settecenteschi di Henry Purcell. a tutto questo si aggiunga la naturale attitudine bucolica di molta musica folk che, senza scomodare i santi, tesse un lungo percorso che potrebbe andare, più o meno, da Nick Drake all’altettanto amata Baby Dee. nel bel mezzo di questo giardino così determinato da miei confini conosciuti e dalle mie traiettorie passate non è difficile riconoscere queste creature del giardino di Lady Walton e addentrarsi serenamente verso ulteriori camminamenti.